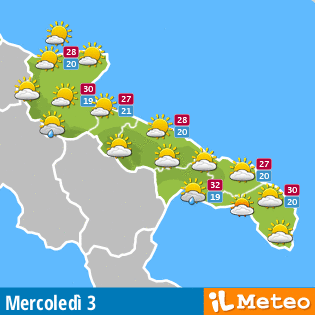COME ERAVAMO / LA SPESA AL MERCATO COPERTO
di Raffaele Polo ______

Parliamo degli anni Sessanta. Allora, andavamo a fare la spesa al mercato, sotto la tettoia Liberty addossata al Castello di Carlo V, almeno un paio di volte alla settimana. Gli altri giorni, il pane e altre piccole cose le potevamo comprare da soli, su precise disposizioni della mamma. ‘Prendi sette etti di cornetti da Padula’ mi diceva. E a me veniva da ridere per quella specie di scioglilingua dei ‘sette etti di cornetti’ e meno male che non erano otto etti sennò avremmo compitato ‘cornotti’…
Insomma, a quei tempi non era assurdo o un disonore ‘fare la spesa con un genitore’. Anzi, il mondo attorno a noi lo conoscevamo proprio in quelle occasioni, i nomi dei venditori li apprendevamo subito: Lojacono, Napolitano, Caffè Orlando, Cagnazzo, La Bomba atomica…
Ma il mercato era certamente il luogo più affascinante, ogni volta mi divertivo a contare gli avventori che si aggiravano tra le bancarelle masticando il ‘mezzo filone’. Una volta ne contai 15, e tutti avevano la ‘porchetta’ (a Lecce la mortadella si chiamava così) come imbottitura…
Più di ogni altra cosa, erano le grida dei fruttivendoli che si pubblicizzavano e cercavano di coprire i concorrenti con la forza della propria voce, ad emergere. Non parliamo poi della parte finale del mercato, quella verso la piazza delle Poste: lì c’erano i venditori del pesce e, soprattutto, il pavimento perennemente bagnato e maleodorante.
Allora, come del resto anche in tempi attuali, si sposavano due consuetudini: o andare presto, la mattina, a fare compere, per avere la merce (soprattutto il pesce) più fresca, o aspettare la fine delle contrattazioni, quando le bancarelle venivano coperte e gli stand chiudevano. Allora, la merce rimasta veniva offerta a prezzi vantaggiosissimi, anche se finivi per tornare a casa carico di chili e chili di frutta e verdura che veniva offerta sempre allo stesso modo: ‘Nà, signora, pigghiala tutta ca te fazzu lu prezzu bonu!’
Le mia preferite, in quella sorta di Presepe profano, erano due donne non più giovanissime. La prima, vendeva ferri lunghi e acuminati. La mamma mi spiegava che servivano a fare la lana ma soprattutto a confezionare i rotolini di pasta fatta a casa che avevano nomi particolari: minchiareddi, maccaruni e maritati quando erano mescolati alle orecchiette, che si chiamava ‘caturu’.
Poi, c’era l’altra, sempre seduta al suo banchetto, che vendeva le uova. Credo si chiamasse l’Antunietta de l’oe ma non sono sicuro… Le uova mi piacevano moltissimo, la mamma comprava quelle fresche (Cu nu bessenu coatizze!, ammoniva la venditrice, che sorrideva) e il giorno stesso, tornati a casa, ne scaldava uno e me lo faceva ‘alla cocca’.
C’era un curioso oggetto che serviva proprio a quello, a contenere verticalmente l’uovo. E, rotto delicatamente il guscio nella parte superiore, potevamo introdurvi molliche o sottili fettine di pane, ripescandole col cucchiaino. Apprendemmo poi che l’uovo, consumato a quella maniera, era in realtà definito in francese ‘a la coque’ perché ricordava il verso della gallina che lo ha appena prodotto… Per noi rimaneva il piacere di quel guscio perforato, ricco di saporito contenuto che ‘ci faceva bene, ma non esageriamo’ come diceva la mamma. C’era poi una cerimonia che ci piaceva molto: nelle fredde mattine invernali, l’uovo era mescolato allo zucchero e al marsala, formando la densa crema di zabaglione che ci affrettavamo ad assaggiare, prima che venisse aggiunto il caffè , in quei tazzoni grandi nei quali tuffavamo il nostro volto di bambini.
Che volete, a volte capita che certi sapori non li sentiamo più. Come ciò che garbatamente vendeva Antonietta de l’oe.
Category: Costume e società, Cultura