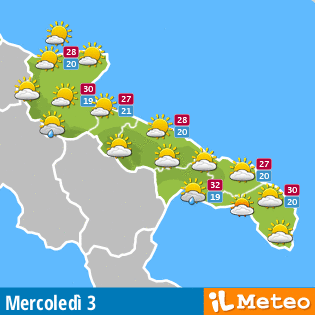L’INTERVISTA / QUANDO LA DANZA E’ UNA SCELTA DI VITA. PER I DICIOTTO ANNI DELLA ‘NEW BALLET’ A leccecronaca.it PARLA LA COREOGRAFA ALESSANDRA SEMERARO: “Vi racconto il mio viaggio artistico magico e continuo”
 di Francesco Buja______
di Francesco Buja______
Il 9 settembre Alessandra Semeraro, una delle luci salentine della danza, ha brindato alle diciotto candeline spente dalla sua compagnia di ballerine. La simbiosi con l’arte di Tersicore, le allieve, le cure ricevute da Raffaele Paganini, il suo metodo afro in continua evoluzione, il ruolo di Cenerentola: a leccecronaca.it la coreografa di Monteroni di Lecce racconta se stessa e il spiega il successo della sua scuola.
In questi tempi di barbarie dilagante, di scarsa attenzione alle arti e a ciò che nutre lo spirito, cosa ha fatto mantenere viva la “New Ballet” addirittura per diciotto anni?
«L’unione di un gruppo di persone che prima erano piccoline, poi son diventate donne. Non era facile. Sono stata brava a mantenere un equilibrio tra chi aveva più capacità e chi sa fare meno bene una cosa. E le ragazze hanno saputo unirsi tra di loro con rispetto, che non è sempre facile, perché stare insieme per molte ore porta a vedere l’altro come è nella vita privata e non più solo come artista. Ci ha unito dividere la vita privata dall’arte. Il segreto è stato vedere queste arti non come qualcosa per diventare ricchi, perché io ho sempre visto la danza come qualcosa che mi faceva arricchire dentro».
È innegabile però una forte domanda di danza…
«Nel piacere di ballare c’era altro, perché la danza ti chiede tanto, specialmente se la fai a certi livelli. Quindi le ragazze hanno poi iniziato a vederla come una scelta di vita, a cui dedicarsi completamente. E il bello è che nonostante siano passati tanti anni le ragazze sono sempre più motivate».
Lei ha inventato il metodo “Modern afro contaminato”: in cosa consiste?
«È nato un po’ di anni fa da una mia idea di creare un metodo di danza totalmente nuovo, perché spesso si chiedeva se nella mia scuola si adottassero metodi già conosciuti e mi dava fastidio non essere cercata per qualcosa di mio.
Io sono stata una bambina curiosa delle cose che nessuno faceva e infatti da piccola, avevo dieci anni, ho seguito un corso di danza afro con una bravissima insegnante ballerina che si chiama Regi Duarte. Eravamo in pochissime perché l’idea di stravolgere totalmente gli schemi della danza classica spaventava. Ma è stata una grande intuizione perché facendo quello ho capito che volevo inventare qualcosa.
E allora ho creato il “Modern afro contaminato”, che è la mescolanza tra la danza moderna e quella africana. Contaminato perché questo metodo non si definisce solo in quel momento e per sempre, ma la contaminazione è continua. Modern afro è la base, ma la contaminazione deriva da qualsiasi cosa, magari anche da questa intervista. Adesso ci sto aggiungendo un po’ di yoga».
È stata casuale l’incontro con la cultura africana?
«All’inizio è stato casuale, ma ora nutro molta curiosità, tant’è che mi sono rivolta a un’associazione che organizza dei viaggi di gruppo in Africa per portare l’arte. L’afro è proprio il contatto con la terra, col sole, con l’ aria e col vento, quindi i bambini africani potrebbero insegnare a me il movimento delle mani e dei piedi nella terra. Mi chiamano “la ballerina scalza”, perché devo sentire il contatto col pavimento».
Ha anche adottato il metodo Matt Mattox: ce lo illustra?
«Ho conosciuto il maestro Mattox quando avevo undici anni in un collegio a Venezia, dove sono stata per qualche mese. Al mattino andavamo a scuola nella stessa struttura e al pomeriggio si studiava danza per sette, otto ore di fila.
All’inizio è stata molto dura, ma ho accettato questa opportunità perché ho sempre creduto in una sorta di destino e ho voluto vedere dove mi avrebbe portato questa esperienza. Il maestro aveva una settantina di anni ma danzava come un ragazzo di venti e quando finivamo la lezione lui andava a fare footing.
Il suo è stato un metodo che mi ha insegnato la velocità del movimento e quella di elaborare più passi contemporaneamente: le braccia facevano una cosa e le gambe ne facevano un’altra. Partiva con un ritmo e poi lo accelerava sempre più, quindi noi dovevamo essere brave a coordinare braccia e gambe e credo di aver imparato a ballare grazie a lui».
Da dove trae ispirazione per creare le coreografie?
«Io prendo spunto dalle persone che si raccontano a me, a volte sono autobiografiche, altre volte no, anche perché un bravo artista deve sapersi immedesimare».
Ha lavorato con Raffaele Paganini, Maurizio Nardi, Gaudin e, fra gli altri, con Palacios e De La Roche: chi le ha dato qualcosa in più?
«Paganini io lo chiamavo “il mio papà”. Io ho un padre straordinario perché il primo a credere in me è stato lui. Ma Paganini mi ha fatto da papà quando ero lontana da casa per la danza. E quando ho aperto la scuola è stato il primo maestro che ho invitato e mio padre lo ringraziò per come era stato paterno con me.
André De La Roche pure mi ha dato tantissimo. Quando veniva ospite della mia scuola non voleva andare in albergo, chiedeva un divano a casa mia per dormire, perché aveva sperimentato le difficoltà di chi studia danza.
Maurizio Nardi l’ho conosciuto per il “Key West modern dance”, festival a Miami, per cui fui scelta come unica italiana nel 2012: con lui ho affrontato questo corso di formazione in Florida, in virtù di una borsa di studio che non sapevo se accettare. Alla Fiera della danza a Firenze, infatti, seguii una lezione con questo maestro. Lui era calabrese, ma noi non lo sapevamo, ci chiese da dove venissimo e disse di voler far vedere cosa sforna il Sud e mi diede questa borsa di studio. Io non ci volevo andare, perché ero mamma da poco, avevo due bambini, il più piccolo era di nove mesi, quindi dissi di questa opportunità solo a mio padre. E lui mi chiede: “Pensi che i tuoi figli vogliano una mamma infelice per aver rinunciato a un’esperienza così importante?”. Allora decisi di partire.
Maurizio Nardi, artista dell’American Ballet, aveva attuato il metodo preso da Martha Graham, che ho imparato e che mi ha aiutato poi per perfezionare il mio. Consiste nella contrazione del corpo e nel rilassarlo allo stesso tempo. Difficile, però ti dà la coscienza di ciò che sei e di quel che fai: inizi a sentire il corpo veramente mentre balli, non sei più tu a sentire la musica, ma è come se la musica uscisse dal tuo corpo».
Come definirebbe il suo viaggio artistico?
«Finora lo definirei “magico” perché mi ha regalato delle cose a cui non ho saputo dare spiegazione. E sicuramente un viaggio “continuo” perché vedo ancora tanta strada davanti a me».
Carla Fracci non vuole essere ricordata quale icona della danza, ma come una donna forte che con la professionalità è diventata un riferimento: lei invece a cosa aspira?
«La capisco, perché quando le mi allieve dicono di voler diventare come me, questo mi fa molta rabbia. Ho detto: “Voi non dovete aspirare a essere come un’altra persona, per quanto la possiate ammirare”. Non ho mai cercato di assomigliare a qualcuno: non guardo mai film sulla danza e non leggo mai libri autobiografici di chi danza, perché mi distrarrebbe da ciò che voglio essere io. Miro a far danzare le ragazze in un certo modo e a far sì che dicano sempre “grazie” per ogni cosa successa, perché nulla è mai perso, ma ci lascia sempre qualcosa.
Del resto, chi stabilisce chi è l’icona? Lo si è in base alla fortuna di una persona di diventare più famosa di altre? Ma a volte proprio quella che ha dato tanto non la conosce nessuno. Non è un mito chi noi vediamo sulla bocca di tutti».
Giulietta, Giselle, Aurora, Isadora: quali di questi personaggi ha impersonato?
«Isadora Duncan no, ma ne ho sempre parlato molto alle mie allieve, perché mi piaceva molto il fatto che lei avesse sconvolto delle regole. E comunque portato una trasformazione della danza, perché lei ha rivoluzionato nel modo di ballare e di vestire la danza.
All’epoca (tra la fine dell’Ottocento e il primo Novecento; ndr) fu uno shock, perché i suoi veli leggeri dei tutù furono visti come un affronto a ciò che si faceva nei balli di corte. L’ho amata perché mi sono identificata in lei, perché amo stravolgere quello che è visto come normale.
Invece ho interpretato Giulietta, Aurora, in spettacoli non solo miei. Non sempre è facile sentirsi ciò che si deve interpretare».
Lei come si immedesima nelle donne che interpreta?
«Quando mi viene dato un ruolo non lo vedo solo per la danza, ma nella vita. Quindi inizio a sentirmi Giulietta nella vita di tutti i giorni. Mi faccio chiamare “Giulietta” o “Aurora”, perché devo sentirmi quel personaggio già tanto tempo prima dello spettacolo. Cerco di capire chi era, cosa faceva, dove voleva arrivare e io divento esattamente quella persona».
Quale personaggio è rimasto intrappolato in lei?
«A me è rimasto il ruolo di Cenerentola. L’ho interpretata nel 2006 a Lecce in chiave moderna. Si ribellava non grazie a un principe, ma grazie a se stessa. Lo spettacolo si chiamava “La rivolta di Cenerentola”: lei si ribellava alla matrigna e alle sorelle sdoppiando la sua identità, quindi diventava in dieci. Rappresentava la forza, la rivolta della donna. Fu talmente apprezzato che qualche mese dopo mi venne consegnato, in occasione de “Il Sallentino”, il premio per la migliore coreografia di una compagnia emergente.
Ogni personaggio che interpreti non te lo togli più di dosso, a volte lo vivo ad alta voce, la gente si sorprende. In Cenerentola ho identificato molto me stessa».
Lei ha studiato alla “Unghery Ballet” di Liegi, ha danzato in Spagna, a Budapest e in Atene, oltre che al Nord Italia, quali differenze ha riscontrato rispetto al Sud della nostra nazione?
«Forse l’unica differenza è che al Nord e all’estero c’è più coscienza dell’arte. Eppure, secondo me, l’arte nasce al Sud. Però al Nord e all’estero, ho notato, c’è più riconoscimento di quest’arte; qui invece è quasi come se fosse scontata. Lì ho sentito di più l’essere ballerina, l’essere coreografa: viene riconosciuto come lavoro, anche se per noi è qualcosa di più, è la vita. Mentre al Sud, a volte mi chiedono cosa faccio nella vita oltre alla coreografa».
Due anni fa ha vinto il talent show “Bravissima” di Sky: cosa pensi della danza in tv?
«Nell’esperienza televisiva non mi ci vedo, perché è molto diversa da quella del teatro e delle piazze. Quello è stato un talent fatto un po’ per gioco, perché volevo vedere come un ballerino o un coreografo vivesse la televisione: è molto diverso, per i tempi, gli obiettivi, le dinamiche.
I tempi sono più schematici e rigidi, invece in teatro ti puoi concedere la libertà di essere un po’ più te stesso e lasciare spazio al sentimento. In televisione tutto è stabilito, c’è poco di naturale».
E qual è la differenza tra danzare in teatro e farlo in piazza?
«Quando frequentavo ancora la scuola di danza, la mia insegnante era molto contraria alle piazze, diceva che togliessero la magia del teatro. Cioè ti portavano a togliere quel distacco dal pubblico che serviva a prendere l’energia dagli spettatori ma non tanto da compromettere la riuscita dello spettacolo. Negli anni ci siamo dovuti adeguare, in un contesto come il Sud, dove purtroppo a volte dà più sbocco una piazza che un teatro; quindi ho preso più energia da un pubblico in piazza che da quello in teatro.
Il pubblico a volte va educato. La danza è immediata, un’arte che ti dà subito il risultato: dalle piazze ho ricevuto il riscontro più bello».
Dunque quali soddisfazioni le danno le allieve?
«Le più piccole mi danno una soddisfazione anche come mamma, perché riesco a spiegare loro con amorevolezza, ponendomi col loro linguaggio, al loro stesso livello, non tanto quindi da insegnante, ma stimolandole, come chiedono in continuazione i bambini di oggi. Devi essere veloce, ma far gustare le cose. Voglio essere ricordata da loro non per la foto scattata ma per lo sguardo che ha trasmesso qualcosa.
Le altre mi danno la soddisfazione di aver compreso il mio lavoro quando mi fanno ancora tante lettere scritte a mano. A volte passano i pomeriggi a colorare i disegni. Allora lì capisco che il mio lavoro è rimasto autentico. Per le più grandi non sono solo la loro insegnante, ma la persona a cui si rivolgerebbero per prima se capitasse loro qualcosa».
E le pubbliche Istituzioni sono vicine alla danza?
«Ho collaborato con una scuola francese che si chiama “Les balladins”, l’insegnante di quella scuola mi aveva chiesto delle coreografie: mi è rimasto impresso che a Parigi dessero il teatro e un ufficio per lavorare, invece qui da noi se vuoi aprire una scuola di danza devi avere le tue forze economiche. Non si dà fiducia a chi è nuovo del settore. E io senza mio padre, che di nascosto mi ha trovato e allestito il locale dove lavorare, non ce l’avrei fatta».
Category: Cultura