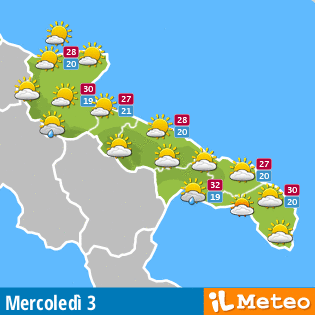PARLANDO DEL SUO ROMANZO SUL ’69, GIUSEPPE RESTA SI RACCONTA A leccecronaca.it E POI, SUL FILO DELLA MEMORIA, ARRIVA AI GIORNI NOSTRI

di Emanuela Boccassini______
In occasione dell’ uscita del romanzo, recensito ieri, abbiamo rivolto all’ autore qualche domanda.
D.) Perché ha ambientato il suo romanzo proprio nel 1969? Cosa rappresenta quest’anno per l’Italia e per Luigi?
R.) Ho sempre pensato che i fermenti del ’68 abbiano avuto vera concretizzazione nel ‘69. E che quest’anno, per il mondo occidentale, sia il vero anno spartiacque tra la fine di un vecchio mondo e l’inizio del nuovo. Nell’ultimo romanzo di Malvaldi un suo personaggio si chiede se mai si fosse fatto caso a come cambiano le fotografie di famiglia tra il 1967 e il 1969. Un ante quem e un post quem che ha segnato proprio visibilmente una cesura sociale, economica, politica, comportamentale. Quindi anche di rapporto con il consumismo, con il linguaggio, con l’erotismo.
Nella prefazione indico alcuni avvenimenti simbolo di quel cambiamento epocale: il suicidio di Jan Palach, l’uomo sulla luna, l’ultima esibizione dei Beatles (30 gennaio 1969, Londra, sul tetto della Apple Record, nella foto, ndr.), il festival di Woodstock per finire con gli attentati e la strage di Piazza Fontana, che segnò la fine dell’Autunno Caldo sindacale per aprire la triste stagione degli anni di piombo. È anche l’anno della legge Codignola che rese libero l’accesso alle università.
Lu Luigi è il protagonista che inconsapevolmente vive il suo passaggio adolescenziale in queste realtà che cambiano. Cambia lui, cambia il mondo che ha attorno. Entrambi cambiano con tormento e turbamento, essendo incapaci di scegliere con determinazione ciò che valeva la pena cambiare e quello che andava assolutamente conservato. Non sempre si scelse bene. Almeno ora, dopo cinquant’anni, è facile dirlo con il senno di poi.
D.) Ho letto una certa nostalgia nel testo. Se non ho interpretato male, che cosa rimpiange di quell’epoca?
R.) La nostalgia è per un piccolo mondo antico fatto di rapporti umani, di condivisione dignitosa della povertà con senso di fratellanza e dignità. Per i paesi legati da rapporti di vicinanza, dai riti, dalle consuetudini. Tutte cose che ancora sopravvivono nei centri piccolissimi, ma che i centri appena poco più grandi hanno definitivamente perso. Per esempio, nel romanzo parlo del rito del lievito che si passava da famiglia in famiglia per tutta una strada quando il pane si faceva in casa. Una piccola cosa che legava e univa più dei rapporti di sangue. E profumava di genuino e di buono. E poi c’era una società che non aveva grandi separazioni per età, per censo, per cultura. La piazza, la parrocchia o il bar erano luoghi democratici aperti a tutti e dove c’era un’osmosi paritetica tra tutti, pur rispettando e riconoscendo sapienza, cultura ed esperienza.
D.) Quali sono secondo lei le differenze più importanti tra Nord e Sud e tra il 1969 e il 2018?
R.) Non ho mai creduto in una differenza geografica tra un Nord e un Sud. Conosco bene il Nord, anche di più il centro dell’Italia dove ho vissuto per una decina di anni, per avere certezza che non è un problema di paralleli ma di civiltà. Solitamente si parla del Nord facendo riferimento a quello delle fabbriche, del terziario avanzato, delle grandi città e dell’inurbamento. Ma basta andare nei borghi agricoli per trovare la stessa atmosfera degli stessi posti del Sud. Così se si va nella zona industriali di Napoli o di Palermo, o di Taranto, sembra di stare molto più a nord.
La differenza è nella distanza che si ha dall’economia agricola, dal rapporto con la natura ed il territorio. La differenza – parlando da architetto – è tra i luoghi e i non luoghi. Se è vero che l’uomo è ciò che mangia è anche vero che l’uomo è ciò che abita. Un mio antico amico giornalista mi disse una frase che non scorderò mai –Eravamo indietro, perciò domani saremo avanti –: bisogna ripartire dal passato per ricostruire su fondamenta solide un nuovo futuro meno legato all’effimero.
Tra il 1969 e il 2019 – quasi ci siamo!- intercorrono cinquanta anni tra le speranze per un progresso senza fine e la triste constatazione che quelle non erano vere. Tempo fa un mio caro amico commerciante, uno di quelli che ha iniziato letteralmente con le pezze al culo ma ha avuto doti, capacità e visioni che l’hanno portato a realizzare grandi cose, mi disse che solo quindici anni fa se qualcuno gli avesse predetto che saremmo dovuti giungere a questa crisi sociale, culturale ed economica l’avrebbe preso per pazzo. Eppure è uno che ha sempre visto molto più avanti. Ma questa crisi di uomini ha portato ad una crisi economica inaspettata, sorprendente. Si è invertito in negativo l’andamento dello sviluppo.
D.) Non mancano dardi contro la società attuale: si stava meglio quando si stava “peggio”?
R.) No. Questa è una di quelle frasi che mi danno estremamente fastidio. La trovo stupidamente reazionaria. Ogni epoca ha i suoi pro e i suoi contro. E forse è vero che, se non ci siamo ancora estinti del tutto nonostante tutto e nonostante noi umani ci proviamo spesso, i pro di ogni epoca sono stati sempre un po’ più grandi dei contro.
Ho sempre contestato il fatto che la nostalgia della giovinezza, per gli anni della spensieratezza, sia l’anestetico per delle mancanze economiche e sociali. In quelli anni c’era maggiore povertà, malattie infantili gravi, strascichi delle esantematiche e della polio che invalidavano tanti, anche miei compagni di scuola. Poi c’era un alcolismo diffuso e grave, con le strade dei paesi che di sera si riempivano di ubriachi fradici. Per non parlare di violenze fisiche su donne e bambini, accettate come normali, e incesti e violenze sessuali e sfruttamento minorile.
Nel romanzo cerco di far passare sotto traccia molte di queste tristi realtà di quei tempi. Chi si ricorda più oggi dei geloni? Chi ne soffre più? Chi tra i giovani sa cosa sono? Invece all’epoca mani e piedi gonfi e doloranti erano la normalità per chi viveva in case senza riscaldamento e senza acqua corrente calda. No: si stava peggio quando si stava peggio. Poi la memoria è un setaccio che in molti fa passare i ricordi pessimi e trattiene solo quelli buoni. Ma allora c’era veramente più fame e miseria diffusa di oggi. Forse non meno di domani.
D.) Quando e dove abbiamo sbagliato, secondo lei?
R.) Abbiamo sbagliato nel considerare tutto conquistato, tutto dovuto, tutto dato per scontato. Abbiamo sbagliato quando abbiamo fatto un passo indietro delegando, lasciando fare.
Abbiamo sbagliato quando abbiamo considerato lo Stato una cosa diversa da noi, qualcosa da mungere, da spennare, da sfruttare senza chiederci da dove provenivano quelli stipendi, quelle pensioni, quei contributi, quei soldi per quelle opere pubbliche faraoniche quanto inutili.
Abbiamo sbagliato quando abbiamo sotterrato il buon senso della civiltà contadina, quella che faceva fare il passo più corto, quella che era ospitale, che soccorreva il bisognoso anche se si aveva poco, quella che “dove mangiano quattro mangiano cinque”.
Abbiamo sbagliato quando ci siamo scordati che eravamo poveri, morti di fame, emigranti anche noi, i nostri padri, i nostri nonni. E abbiamo sbagliato a non considerare che potremmo tornare ad esserlo.
D.) Lei scrive «non ci sono più misogine delle donne stesse», perché?
R.) Perché di fronte ad una sbandierata, e pure in parte vera, solidarietà femminile si vedono, sentono e leggono tanti esempi di donne l’una contro l’altra ferocemente armate. Pochi giorni abbiamo avuto l’esempio delle mamme e delle fidanzate degli stupratori che aggredivano verbalmente la vittima e osannavano gli uomini che avevano commesso l’orribile fatto. Alcune donne parlano delle altre con grande acredine, preconcetti, stereotipi e riserve mentali che nemmeno ai peggiori maschilisti verrebbero in mente.
D.) Considerati il tessuto sociale, le aspirazioni, la “politica” ‒ come la intende lei nel romanzo ‒, Luigi e quelli come lui hanno avuto modo di realizzare i sogni di riscatto sociale?
R.) In quegli anni il cosiddetto “ascensore sociale” era attivissimo. Uno dei frutti del Sessantotto, sicuramente, e anche di quella legge Codignola che proprio nel 1969 aprì l’accesso libero all’università e dei “presalari” che permisero a tanti studenti di famiglie umili di frequentare atenei lontani. Il grande maestro Guccini nell’Avvelenata del 1976 canta “son della razza mia, per quanto grande sia, il primo che ha studiato.”
Ottenere una laurea consentiva di riscattarsi dalle ataviche ristrettezze, perché in qualche modo apriva le porte o alle libere professioni o all’ingresso nelle amministrazioni pubbliche e private. E così anche i diplomi, che aprivano ancora tante porte. Prime fra tutte quelle agognate delle banche. E il bravo imprenditore aveva spazi anche nel commercio e in ogni impresa. L’iniziativa era premiata. Certamente questo comportò anche una crescita della consapevolezza, una rivalutazione della cultura locale, del vernacolare. Si ricominciò ad avere l’orgoglio delle proprie tradizioni che fascismo e guerra avevano cancellato.
Tutto questo si è perso con il diffondersi dell’Edonismo Reaganiano degli anni ottanta. E in questa confusione di nani, ballerine, ricchi premi e cotillons, in quest’Italia da bere e da mangiare fino all’osso, si sono perse le basi sociali sulle quali era fondata l’Italia della ricostruzione e della Costituzione repubblicana nata con la Resistenza. L’abdicazione alla resistenza giorno per giorno non ci ha giovato. Dopo il riscatto sociale è ritornato l’egoismo, in una variante ancora peggiore del familismo amorale. E l’egoismo è l’antitesi della socialità. Chi ha realizzato quei sogni oggi, così, rischia di vederli dissolvere.______
LA RICERCA nel nostro articolo di ieri