“Ad una cena di lavoro”, RACCONTO INEDITO DI DARIO PEREZ IN ESCLUSIVA PER I NOSTRI LETTORI
 di Dario Perez______
di Dario Perez______
“Ogni storia da me scritta nasce dalla asfittica realtà che ci circonda. Ogni vicenda vissuta può essere dilatata, estremizzata e distorta e così la gente che, giorno dopo giorno, incontriamo, sfioriamo, viviamo può diventare il mostro che terrorizza le nostre esili esistenze.”
(Rdl______Dario Perez, nato a Mesagne, 32 anni, è laureato in lettere moderne.
Esordisce con il romanzo “Luce nel buio”, pubblicato da Icaro Editore, nel 2009.
A “Notte Fonda, raccolta di racconti horror e thriller, è la sua seconda pubblicazione, appena edita da Sillabe di Sale Editore.______
leccecronaca.it gli ha chiesto in esclusiva un racconto inedito per le ‘innocenti evasioni’ estive dei nostri lettori.
Qui di seguito, quello che ci ha mandato con un’ immagine dell’ illustratrice Adriana Tosi)______
AD UNA CENA DI LAVORO
Mi ritrovai nella mia automobile. Dovevo andare a quella maledetta cena di lavoro con tutti i colleghi che neanche avevo mai conosciuto. Guardai l’orologio. Ero in ritardo. E gli squali non avevano la propensione all’attesa.
Con l’ansia che mi era entrata in circolo pigiai più forte il piede sull’acceleratore per arrivare al punto dove, di solito, ci s’incontrava. Dovevo assolutamente salvare il salvabile recuperando più tempo possibile e, nel frattempo, inventare una scusa per giustificare la mia colpevole mancanza di puntualità.
Giunsi a destinazione. Finalmente. L’enorme parcheggio del fatiscente supermercato era gremito di gente e di auto che ammiccavano con i loro occhi bianchi e luminosi. Che strano! Non mi ero mai reso conto dello stato d’abbandono di quel grigio e poco attraente stabilimento. Ero perfino passato da quello spiazzo poche ore prima e tutto mi era parso regolare. Cercai di comprendere. Mi ero quasi smarrito nelle mie sterili elucubrazioni quando la mia attenzione fu presto attirata dalla presenza tutti i miei colleghi, i quali erano accompagnati dalle rispettive compagne, tutte vestite di viola; sembravano tante meduse con i tacchi alti che, maldestre, cercavano di muoversi in quel mare di cemento e ipocrisia.
Sembra che debbano andare ad una serata di gala. Pensai. Odiavo quell’ambiente in cui ogni persona era valutata in base ai dannati quattrini che riusciva a guadagnare. Non c’era spazio per mostrare ciò che si aveva dentro. Era solo quello che racchiudeva il tuo portafogli a darti una precisa connotazione in un freddo manipolo di arrivisti senza scrupoli. Cuori finti che battevano solo per l’emozione provocata da una banconota messa in tasche profonde come fredde e fameliche voragini.
Provai a reprimere la rabbia e mi misi alla ricerca di un posto in cui parcheggiare il mio catorcio. Trovai presto la giusta collocazione. Il più lontano possibile dalle fuori serie dei rampanti manager, o presunti tali, presenti quella sera; lontano dai fari indiscreti di veicoli che, meglio degli stessi proprietari, riuscivano ad esprimere un’aria quasi “stronzeggiante”.
Aprii il pesante sportello e scesi dall’auto e fu proprio in quel momento che mi resi conto del mio abbigliamento. Era ridicolo. Io ero ridicolo.
Non è possibile… ricordo di aver indossato la mia unica giacca comprata in quel negozio di abbigliamento scadente e Made in China. Come mi ritrovo in t-shirt e infradito?
Stava succedendo qualcosa di strano. Mi sentivo strano. Continuavo a guardarmi i piedi cercando di sfuggire agli sguardi taglienti come lame arrugginite di quelle persone che attendevano impazienti l’ora dello scrocco. L’ora in cui ci si abbuffava senza pagare. Si mandava giù, a grandi bocconi, un po’ della propria anima.
Fortunatamente mi resi subito conto delle mie condizioni. Corsi nuovamente verso l’auto. Dovevo andare a cambiarmi d’abito. Già ero giudicato male per la mia scarsa inclinazione agli affari, se mi avessero visto conciato in quel modo, mi avrebbero presto crocifisso come un Cristo smidollato e squattrinato. Chi non fatturava era sempre soggetto agli sguardi di finta, e armata di coltello, costernazione.
Saltai nell’abitacolo. Un po’ frustrato, azionai il motore. Ero sconcertato e continuavo ad avvertire quella costante sensazione che mi faceva sentire come se avessi uno spillo conficcato nel sedere. Avevo fretta. E più il tempo scorreva velocemente, più ogni singola azione si dilatava nel tempo. Mi sembrava di muovermi in modalità slow motion. Tutto intorno a me andava piano. Troppo piano. Chiusi gli occhi e, non so ancora spiegarmi come, mi ritrovai in cima ad un palazzo. Non ero a casa mia. Mi sentivo stordito ma allo stesso tempo continuavo a udire il ticchettio di un orologio invisibile, il quale mi metteva addosso un’enorme fretta.
Scesi al piano sottostante e, improvvisamente mi parve di trovarmi proprio sul pianerottolo dell’abitazione di mio fratello. Ancora ne ignoro il motivo ma, in quell’istante, mi sembrò una cosa normale.
Mi presterà lui qualcosa da indossare. Pensai. Osservai bene le tre porte che erano poste una di fianco all’altra nel caposcala. Uno sguardo alle nere rampe. Le porte erano diventate quattro; vicino alla quarta c’era un passeggino che si muoveva da solo. Fu una visione inquietante. Mio fratello e mia cognata non avevano figli. Rimasi a guardare quella scena, poi con passo incerto mi appressai al carrozzino. Dentro vi dormiva una bambola… ciò che ne restava almeno. Sotto delle copertine bianche era ben riposto il corpo di un bambolotto, il quale non aveva la testa.
All’improvviso… delle risate. Aumentavano gradualmente d’intensità e volume. Erano insopportabili. Cercai di aprire il portone dell’abitazione in cui pensavo abitassero i miei familiari; era socchiuso e un piccolo spiraglio mi faceva intravedere ciò che l’appartamento custodiva. Niente. Era vuoto. Una lampadina si accendeva e spegneva seguendo un ritmo strano, come se stesse terminando il suo ciclo vitale sprigionando gli ultimi attimi di luce. Non era una casa che io conoscevo. Mi sbattei il portone alle spalle e scappai via. Ero confuso. Impaurito. Corsi a perdifiato giù per la rampa rischiando di cadere a ogni infido scalino.
Giunto al primo piano, proprio davanti alla porta d’ingresso di una delle infinite abitazioni, mi accorsi che c’era un nano. Mi guardava e scuoteva la testa come se mi stesse redarguendo per un’azione cattiva da me compiuta. Alzai il braccio muovendo la mano per farlo avvicinare. Non sapevo cosa, realmente, chiedergli ma il mio fu un gesto istintivo.
L’uomo di ridotte dimensioni scomparve. Provato, mi aggrappai al passamano e scesi l’ultimo scalino cercando di guadagnare l’uscita e andare chissà dove. Con timore appoggiai la mano sul pomello di un portone rosso sangue e spinsi l’anta verso l’esterno. Un forte bagliore. Chiusi gli occhi. No. No. Non poteva essere.
Mi ritrovai nuovamente sull’attico dell’edificio. Riscesi un’altra volta le scale. Stesse risate. Stesso passeggino. Stesso nano. Non so quante volte ripetei quell’azione. Alla fine rimasi sconfitto sul piano più alto del palazzo. Guardai le nuvole che si rincorrevano al contrario. Il mondo sottostante mi sembrava immobile e muto. Salii sul cornicione. Dovevo cercare di uscire da quella assurda e tremenda ragnatela invisibile. Trattenni il respiro, chiusi gli occhi e saltai. Il volo durò pochi attimi. Mi ritrovai in una sala enorme. Non ero morto. Ne ero uscito illeso. Intorno a me, tanti tavolini imbanditi che muti e proni si lasciavano avvolgere da un irreale, lieve silenzio.
Mi trovavo nel ristorante in cui avrei dovuto cenare, con ipocrita allegria, insieme ai tanti odiati amici. Sudavo freddo. Guardai nei piatti e un istintivo conato di vomito mi colse a tradimento. Tanti vermi fuoriuscivano dalle portate. Scarafaggi scorrazzavano sui tovaglioli anneriti dalla muffa. Colto da una scarica elettrica iniziai a correre con la speranza di trovare un bagno che versasse in condizioni migliori della sala ricevimenti. Tutto riposava in quel luogo. Sembrava che la polvere fosse riuscita a bloccare anche il tempo.
Trovai il bagno e mi fiondai sulla bocca spalancata di un water. Lì avrei potuto vomitare tutte le mie paure. Tutte le mie incomprensioni. Tirai lo sciacquone. Rifeci il percorso al contrario. Le suole delle mie scarpe producevano un rumore che, in maniera esagerata, rimbombava negli ambienti bui del locale … mi guardai i piedi. Indossavo uno scarpino di pelle lucida. Uno specchio lercio, appeso a una parete ormai afflitta da uno stantio grigiore, mi rivelò che indossavo una giacca e un pantalone entrambi arancioni e per cravatta mi ritrovavo un serpente che mi sibilava sul petto.
Arrivai nel salone e lo spettacolo che mi si presentò mi tolse le residue forze che, fino a quell’istante, avevano sorretto le mie sgargianti gambe.
Seduti ai tavoli tanti scheletri divoravano le squisite pietanze fornite dal cuoco Belzebù.
All’ angosciante vista di tanto squallore, la mia provata bocca si aprì per far uscire un urlo colmo di terrore.
Le ossute presenze si voltarono come disturbate da un rumore improvviso. Mi guardarono perplesse e iniziarono a ridere. Le loro stridule risa fecero aumentare in me lo sgomento. Ridevano. Ridevano e io continuavo ad urlare. Urlai fin quando non svenni annegando in una pozza di sudore.
Quando riaprii gli occhi, il frastuono prodotto dalle sguaiate risa non si era concluso.
– Amerigo… svegliati. Ma che ti prende. Hai iniziato ad urlare come un matto…
Continuai a tenere gli occhi chiusi ma avevo riconosciuto quella voce. Era il mio capo.
–Sì, io beh… risposi balbettando.
Non sapevo come spiegare il mio comportamento. Decisi di rimanere in silenzio. Gradualmente iniziai a muovere le palpebre rimaste serrate per chissà quanto tempo. Ero steso per terra e il mio capo, in modo quasi spavaldo e guascone, cercava di farmi prendere un po’ d’aria sventagliandomi vicino al viso una, a me sconosciuta, banconota da duecento euro. Come per dire: Non c’è nulla che una bella e fresca banconota non possa risolvere.
–Salve, dottor Fini… ma cosa mi è successo? Dissi con la poca forza che mi era rimasta in corpo.
L’uomo mi sorrise con falso fare paterno, ma non mi rispose.
Mi alzai con calma, mi guardai intorno. Ero al ristorante e tutto era normale. Tutti mi guardavano e nascondevano le bocche velenose dietro ai fazzoletti per schernirmi di nascosto. Ma cosa mi era successo?
Sicuramente lo stress mi ha giocato uno scherzetto coi fiocchi. Pensai.
Quella era l’unica spiegazione che la mia mente fu in grado di formulare il quel momento.
Stravolto, mi avvicinai all’ingresso di quella lussuosa e lussuriosa struttura.
Non avevo nemmeno fame.
Decisi che avrei chiamato un taxi per andare a casa. Non mi andava né di guidare né di farmi accompagnare da qualcuno degli invitati. Mi sentivo ancora addosso quegli sguardi beffardi. Accusatori.
Da lontano, vidi arrivare un mezzo giallo. Era il taxi che stavo aspettando. Lanciai un fischio e la vettura inchiodò fermandosi a pochi passi dai miei piedi.
Aprii lo sportello posteriore e mi accomodai, sfinito, appoggiando la nuca allo schienale di pelle nera.
Salito, fui salutato da una voce stridula, strana.
Nell’auto, però, non c’era nessuno.
Almeno così mi sembrava, in quanto nel buio e dalla posizione in cui mi trovavo, non riuscivo a scorgere alcuna sagoma seduta al posto del conducente. Il mio sguardo, improvvisamente, si lanciò sullo specchietto retrovisore. Il cuore mi si fermò. Non poteva essere vero.
–Salve, signore dove vuole che la porti? Ih ih ih.
Era il nano che avevo incrociato al maledetto palazzo, di fianco aveva un bambolotto decapitato che muoveva delle braccia troppo corte. Era sorretto dalla cintura di sicurezza.
Non risposi.
L’auto partì. Malinconico e rassegnato, gettai lo sguardo verso il ristorante dal quale ero appena uscito. Non c’era più. Potevo scorgere solo un buio fin troppo muto ed eloquente.
Nella confusione che avvolgeva i miei pensieri avevo capito tutto.
Ora sapevo…
Sapevo che quel viaggio non sarebbe mai finito.
© Copyright
Tutti i diritti riservati
Category: Cultura

























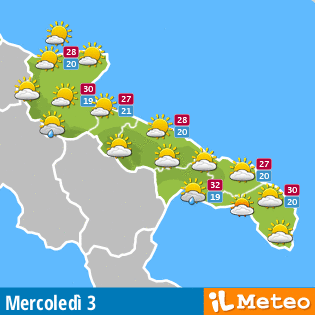









Realmente terrificante…..bellissimo racconto….le parole prendono vita. Complimenti a questo nuovo grande scrittore