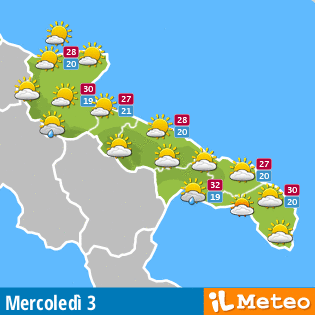LA MIA PASQUETTA MUSICALE ALTERNATIVA

CHIUSO IN CASA, RIPENSANDO AD UN VECCHIO AMORE, BJORK E ASCOLTANDO IL NUOVO, VERA DI LECCE
di Roberto Molle ______
I vecchi amori tornano sempre, oppure siamo noi a tornare da loro… I nuovi possono solo accettarlo, o morire. Lo so, è un assunto un po’ strano, ma è riferito alla mia esperienza di melomane.
Questo mi succedeva molto spesso negli anni Ottanta e Novanta, un po’ meno nei Duemila, oggi quasi per niente.
Non è una questione meramente anagrafica, il fatto è che tutto o quasi in campo musicale è stato già detto; rimangono le sfumature, i riflussi, le variazioni finto-alternative, i cloni di certi musicisti che, invitando quest’ultimi a suonare nei loro dischi e sfasciando qualche chitarra sul palco, credono (o fanno finta di credere) di essere il nuovo, l’incarnazione del verbo (magari rock) a cavallo del primo ventennio degli anni zero. Un nome su tutti? Maneskin! L’ho detto… non volevo dirlo, vabbè l’ho detto.
Dicevo di certi amori vecchi e nuovi che, o si sovrappongono fondendosi dentro un unico trasporto oppure, il continuo, inevitabile confronto può arrivare a farsi complicato e doloroso.
Questa è la storia di due musiciste che mi hanno fatto innamorare della loro musica senza farmi pesare il fatto di essere così distanti tra loro nel tempo e nello spazio.
Il vecchio amore si chiama Björk Guðmundsdóttir, ma tutti la conoscono semplicemente come Björk.

La prima volta che ho saputo di lei mi guardava dalle pagine di una fanzine in bianco e nero. Era il 1986 e lei era insieme ai musicisti del suo gruppo di allora: gli Sugarcubes.
Folletto, principessa dei ghiacci, elfo, eroina da videogioco. Sono tanti gli appellativi fantasiosi che hanno circondato la carriera di Björk da Reykjavik, Islanda. Una carriera che l’ha consacrata star del pop alternativo degli anni Novanta e personaggio tra i più bizzarri del mondo dello spettacolo.
In realtà, il sound di Bjork sfugge alle classificazioni. È una miscela di battiti cupi e tastiere elettroniche, campionature e sinfonie d’archi, su cui si innesta una voce unica, capace di passare da urla sfrenate e rantoli agonizzanti a gorgheggi sensuali stile Broadway. Già undicenne compone un album di canzoni pop demenziali che in Islanda vende settemila copie, diventando Disco di platino. Dal 1986 al 1992 è la voce degli Sugarcubes (alternative-band islandese, come già detto) che abbandonerà in occasione della pubblicazione di “Debut”, suo primo vero album che la farà conoscere in tutto il mondo. A oggi, trent’anni e nove dischi dopo, resta il disco che apprezzo di più nella sua discografia.
Con “Debut”, Bjork conia una nuova formula di pop, in bilico tra techno e avanguardia, capace di appassionare al contempo gli habitué delle discoteche e i cultori dell’indie-rock. Merito di brani sempre potenti e immaginifici, sensuali e ammalianti fin dalle prime note. Ascoltare per credere l’upbeat di “Crying” o la ballata sinuosa di “Big Time Sensuality”, la filastrocca magica di “Venus As A Boy” o le pulsazioni ossessive di “Violently Happy” (quasi un manifesto della sua esuberanza incontrollata), la soffice “Human Behaviour” o l’incedere cupo della splendida “Play Dead”. Un debutto folgorante, insomma: dodici canzoni unite da arrangiamenti superbi e da una voce già inconfondibile, capace di improvvise escursioni di registro e rientri delicati prima di inerpicarsi su sentieri tortuosi e inaccessibili ai più.
Le sonorità sono prevalentemente elettroniche, fredde e siderali, ma Bjork sfodera anche strumenti acustici a sorpresa, come l’arpa che accompagna l’eterea “Like Someone In Love” o il sassofono che gioca a ipnotizzare l’ascoltatore in “The Anchor Song”. Il segreto del disco è anche nella perfetta miscela tra ritmi e melodie, tra suoni e rumori, tra strutture armoniche semplici e arrangiamenti sempre eccentrici e spiazzanti.
Per Bjork è l’inizio di un successo mondiale che sarà poi consacrato da premi prestigiosi e da una decina di milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Uno di quei casi in cui ai trionfi sul versante commerciale si abbina anche il plauso praticamente unanime della critica.
Il nuovo amore (che poi tanto nuovo non è) riguarda la musica e la voce di una giovane artista salentina che risponde al nome di Vera Di Lecce.

Figlia d’arte, il padre Giorgio insieme alla madre (Cristina Ria) sono stati attori di teatro sperimentale e ricercatori nell’ambito della tradizione salentina.
La vidi danzare la prima volta sul palco di un concerto dei Nidi D’Arac; poi dentro un video a fare il controcanto ad Alessandro Coppola (cantante e leader dei Nidi) in “Jentu”, un brano delicato e sognante. Ricordo che rimanendo affascinato dalla voce calda e sensuale e dalla sua presenza vagamente androgina, mi riproposi di approfondire.
Scoprii che dopo aver fatto parte dei Nidi D’Arac per un po’ di anni, ha collaborato anche con ”Arakne Mediterranea” (gruppo folk revival impegnato nella riscoperta e la diffusione di musica e canti della tradizione salentina; fondato tra gli altri, dal padre di Vera, Giorgio Di Lecce n.d.r.). In seguito, oltre a essere una cantante, è diventata una producer e performer che, partendo dalle radici della tradizione, ha sviluppato un percorso di ricerca e sperimentazione cantando in inglese e componendo musica elettronica ibrida, inserendo loop di percussioni di respiro world-music, vocalizzi cyber e suoni sintetici graffianti.
Nel 2012 ha pubblicato un extending play (“Heavy Butterflies”) e nel 2015 “29 seconds”, un album al fianco di Martyn Heyne (chitarrista degli “Efterklang”, gruppo indie-rock danese n.d.r.).
A conforto del pensiero che Vera, oltre a una bella voce, avesse anche un talento creativo molto interessante, arrivavano le notizie di concerti aperti per musicisti internazionali che stimo e apprezzo tutt’oggi: da Anna Calvi a Lisa Germano, fino al gruppo texano dei Balmorhea e all’alt-band nostrana degli Afterhours, nonché (a conferma della duttilità vocale e artistica di Vera) la collaborazione con uno dei mostri sacri della musica popolare siciliana: il poliedrico musicista, attore e ‘suonatore’ di tammorra Alfio Antico.
Per un certo periodo, a iniziare dal 2018, entra a far parte della band di Cesare Basile, uno dei musicisti più interessanti della scena indie degli ultimi trent’anni.
Nel 2020 inizia un percorso di produzione autonoma pubblicando diversi singoli. Le sue esibizioni dal vivo sono caratterizzate oltre che dall’uso di suoni campionati, da pedali multieffetto, synth vocali e da una chitarra elettrica; coreografie di danza marziale completano le sue performance.
I concerti di Vera sono la sintesi della creazione di canzoni visive, vere ambientazioni nate dalla fusione di sonorità tradizionali salentine (e non solo), nord europee e orientali. In estrema sintesi si tratta di salti spazio-temporali tra antico e moderno, tutto attraverso una lingua, l’inglese, spogliata delle radici e resa fluttuante verso un futuro ancestrale.
È del 2021 l’inizio della collaborazione con Manimal Vinyl (giovane e prestigiosa etichetta discografica americana); tre sono i singoli già pubblicati (“Painfall”, “Shelbone” e “Truth” che confluiranno nell’album “Altar Of Love”) oltre alla cover di “Heart And Soul” dei Joy Division. In tutto ciò non manca un ritorno al passato, un rafforzare quel filo ombelicale che la tiene sospesa, artista cosmopolita: di recente ha collaborato all’album “Rimorso” di “Mai Mai Mai” (sigla dietro cui si cela lo straordinario musicista calabrese Toni Cutrone). Vera è presente con “Fimmine Fimmine”, un classico della tradizione salentina trasfigurato in un ipnotico mantra synth-folk di respiro etno/industrial.
Nell’ottobre dello scorso anno è uscito “Altar Of Love”, album del nuovo corso di Vera Di Lecce. Pur avendo preso contatti con lei per un’intervista, poi saltata (colpa mia), l’idea di un ascolto non superficiale del suo ultimo disco non si è concretizzata prima di un pomeriggio quasi plumbeo (che fosse il lunedì di Pasquetta è solo un caso…).
Le fedeli Sennheiser sono pronte, credo che “Altar Of Love” per le caratteristiche con cui è stato realizzato meriti unapprofondito ascolto in cuffia.
Il disco si apre con “Painfall”, un brano che parte con vocalizzi direttamente in loop, sopraffatto di lì a poco da tamburi tribali. Poi cori e una voce asetticamente calda, sfondo naturale per danze davanti a fuochi che non riscaldano. Sullo sfondo una Björk sorniona sembra sorridere soddisfatta della discepola Vera.
“Shellbone”, un martellante intro e la voce di Vera trasfigurata da qualche infernale vocoder vintage (l’idea corre al Peter Gabriel di “The Lamb Lies Down On Brodway”) a far da guida prima che il tutto scivoli dentro uno scratching di suoni acciaiosi e parole che si fanno claustrofobiche, perdendosi dentro oscuri scioglilingua. Ritmi voodoo e languori finali fanno collassare il brano dopo poco più di tre minuti; poi il vuoto del silenzio e l’inizio dell’astinenza.
Attimi di attesa e arriva “Truth”. Scarne note di synth dove poggia una voce-filastrocca tirata fuori da qualche horror b-movie. Un delicato flip-folp accompagna melodie vocali che evocano pop-song di altri tempi e spleen che non se ne andranno mai.
“Jenome” entra in sordina con un incipit che richiama l”Uncertain Smile” (di The The) leggermente rallentata ma con lo stesso mood… solo attimi. La voce è assente, tutto si fa più intimista, sfumato; poi gli incubi continuano a viaggiare sul “Trans Europe Express” dei Kraftwerk in un gioco di citazioni e rimandi che si fa epico.
“Cantroll” si nutre di Oriente e di sogni senza dolcezza. Disincanto, disperazione e ricerca di un contatto, richiamo amoroso fatto di battiti e respiro. La post-umana Laurie Anderson di “Mister Hearthbreak” e il vittoriano Genesis P-Orridge di “Dreams Less Sweet” si incontrano nelle sonorità di questo brano probabilmente a insaputa della sua autrice. La musica è così, si autoalimenta di suggestioni ed evocazioni, si reinventa mille volte rimanendo uguale e totalmente diversa.
“Sorry” nasce con virtuosismi vocali che sbocciano dentro un groove sospeso al dub ipnotico di un basso che gioca su frequenze bassissime. Ancora un brano con un testo costruito su dichiarazioni d’intenti che si fanno accorate e poetiche.
Il martellante incedere di suoni di “Phoenix” trasporta sui lidi di una techno trasognata, sullo sfondo di echi che battono come martelli alle tempie. Quello che si alza è un muro, capace di tagliare in due speranze e paure che possono sciogliersi sulla voce di una nenia dolcissima.
A chiudere è la title track, “Altar of love”. ‘Anche se il mio corpo è morto / sono abbastanza sicura di poter ballare / Anche se il mio corpo è morto / Sono abbastanza sicura di poter ballare / e cantare e suonare attorno a un altare dell’amore…’, così canta Vera nel brano che chiude l’album, a suggello di un viaggio tra incubi e scenari siderali. A ben vedere sono parole di speranza, di non resa; e questo vale su tutto.
L’ascolto di “Altar Of Love” è terminato, e già mi manca. Un album primordiale e futuristico che mi ha conquistato con i suoi mille rimandi e i suoi special guest stars: Bjork, Peter Gabriel, Pschic-TV, Kraftwerk, Joy Division, Laurie Anderson, Depeche Mode, U2 e ne potrei mettere in fila tanti altri. Poi i luoghi evocati: l’Oriente ottocentesco, La Luna siderale, le foreste amazzoniche e le corti salentine.
Ci ho trovato tutto questo nella musica di Vera Di Lecce, probabilmente ho scantonato, lei avrà avuto tutt’altre motivazioni… chissenefrega, la musica una volta creata non ti appartiene più, diventa di tutti come un’opera d’arte che ognuno può ammirare e vederci quello che gli passa per la mente.
Ascolti:
Bjork
Vera DI Lecce
Category: Cultura