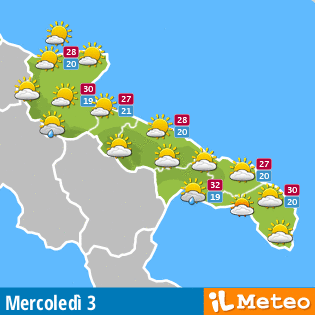COME ERAVAMO / QUANDO IL CALCIO ERA BELLO

di Raffaele Polo ______
Noi eravamo fortunati, almeno in quel frangente. Perché la succursale del Liceo Classico Palmieri, per le sezioni A e B, era al Collegio Argento, negli stessi locali dove si incontravano anche gli iscritti alla ‘Congregazione Mariana’ e dove c’erano, proprio ai lati dell’ingresso, i campetti di calcio.
Intendiamoci: a quei tempi si badava solo alla presenza delle porte che, senza reti e infisse sul duro impiantito (non esisteva l’erbetta e già era molto se c’erano le porte con le traverse, naturalmente di dimensioni inferiori a quelle regolamentari) erano una piacevolissima e realistica eccezione agli altri ‘campi’ da noi frequentati, dove le porte non c’erano e dovevamo cercare delle pietre di un certo volume per inventarcele…
Quindi, quei campetti erano ambitissimi e, anche se il cancello veniva chiuso al termine dell’orario scolastico, era un gioco da ragazzi scavalcare il muro e immergersi in quelle partite senza fine, con i giocatori che crescevano mano mano, sino a riempire tutto il terreno di gioco…
Comandava, naturalmente, chi aveva il pallone. E, a suo insindacabile giudizio, potevi o meno giocare.
La cerimonia, era sempre la stessa. Stavi a guardare i ragazzi che giocavano e poi, alla prima interruzione, chiedevi: “Di chi è la palla?”. Il proprietario fingeva indifferenza e poi ti squadrava; “Quanti siti?” diceva. E, se eravamo un gruppetto, proponevamo una ‘disfida’: ovvero tutti i nuovi arrivati contro chi stava già giocando. Se, invece, era solo uno il richiedente, allora, se voleva giocare, doveva ‘andare in porta’. “Ma io non so parare” dicevamo a malavoglia. Ma, pur di giocare, accettavamo quel ruolo temporaneo che avremmo cambiato quasi subito, soprattutto se la nostra squadra stava perdendo. E ci buttavamo tutti dietro la palla, al grido di ‘passa, passa!’, un grido che, ancora adesso, ci riempie di gioia.
Naturalmente, non avevamo magliette o altri indumenti sportivi. Ma riuscivamo lo stesso a riconoscere i nostri temporanei compagni di squadra: l’unica accortezza erano le scarpe che cercavamo di salvaguardare, soprattutto la domenica. Ma non era facile, c’era sempre qualcuno che assisteva alla partita dietro la porta; “Non posso giocare. Ho le scarpe nuove” affermava con lo sguardo triste. E noi, con le scarpe impolverate e segnate da mille pallonate, non lo invidiavamo certo…
C’erano, poi, le ‘disfide’ tra rioni e caseggiati: allora si andava in campetti di periferia (la Merok, la Simca, il campo delle spine) e le distese di campi incolti finivano per diventare campi di calcio, affollati e spesso fonte di litigi. “C’eravamo prima noi!” dicevamo disperati, quando irrompevano ‘i grandi’ che, senza complimenti, ci cacciavano dal terreno di gioco. “Abbande, mò sciucamu nui” ci diceva il caporione degli invasori che, impietosito, aggiungeva: “Uè sciechi in porta?”.
Pur di giocare, eccoci in porta un’altra volta.
Tornati a casa, sudati e malconci, fingevamo indifferenza e ci tuffavamo sui libri. L’indomani c’era lo spauracchio delle interrogazioni.
Category: Costume e società, Cultura