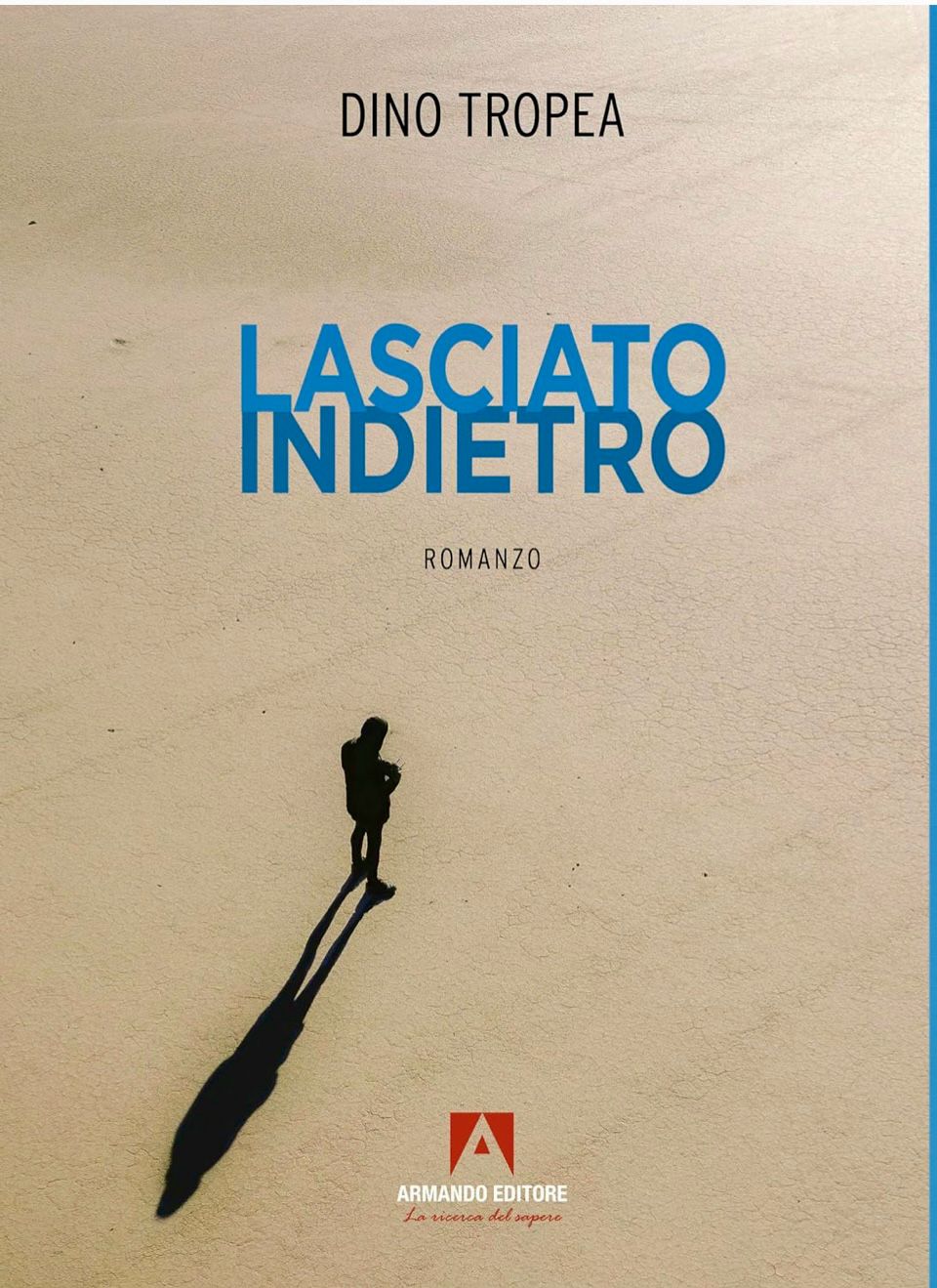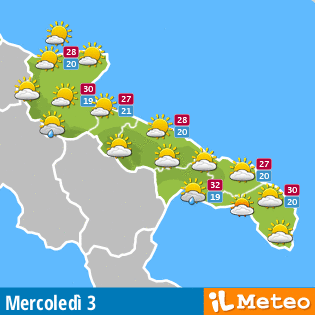IL RACCONTO: INFUSO RITUALE di Erica Zingaropoli
 A seimila chilometri di cielo vive un posto lontano dai profumi di sabbia e dai colori della terra rossa, ha contorni di paglia e legno e movimenti nudi e del vento. Fin dall’alto, prima che l’aereo atterri a Mombasa, in Kenya, lo squarcio di terreni e case marroni ricorda lo scenario visto nei film, nei racconti di fantasia.
A seimila chilometri di cielo vive un posto lontano dai profumi di sabbia e dai colori della terra rossa, ha contorni di paglia e legno e movimenti nudi e del vento. Fin dall’alto, prima che l’aereo atterri a Mombasa, in Kenya, lo squarcio di terreni e case marroni ricorda lo scenario visto nei film, nei racconti di fantasia.
Ma non è fantasia. L’Africa esiste. Lo realizzavo da sola mentre attraversavo a piedi l’aeroporto per immettermi nella Città. L’aria che inebria è leggera e calda al tempo stesso, speziata, intensa e impolverata.
Mombasa non era la mia meta. Lungo il tragitto in auto con Mohammed, l’autista, stringevo la digitale tra le mani, il dito puntava e premeva sul clic ma riuscivo a fotografare solo con gli occhi. Pulmini stracolmi trasportavano gli uomini aggrappati alle uscite, come nelle grandi metrò quando la gente deve fare in fretta per non arrivare tardi a lavoro.
Tulle variopinte intrise di sole, imbevute di luce e di caldo, di spezie e di sabbia, di sudore e di essenze di cocco e frangipani, danzavano come arcobaleni e lambivano i corpi e i visi di donne; donne scalze, dalle braccia ruvide e scure che reggevano sul capo cesti di makuti pieni di piccoli frutti ovali verdi e rossi che Mohammed chiamò kahawa, spiegandomi che i semi venivano essiccati e poi frantumati e uniti all’acqua bollente.
I veli delle donne in cammino coloravano le urla e la disperazione, tingevano le lacrime e fingevano un rituale di gratitudine nel mosaico ondeggiante delle organze, raggianti e ingannevoli. In branco oltrepassavano le distese di terra come masse di antilopi assetate e affaticate in cerca di sollievo. Forti e innocenti, vedovi e orfani, tutti figli di un mondo scritto dal fango e dagli odori, attorniato da alberi a ombrello e rivestito dall’affresco di cielo e nuvole.
Il primo sguardo all’Oceano Indiano mi aveva svelato le onde basse e dorate che dissetavano i piedi dei bambini, intenti a trasportare la legna sulle spalle con un sorriso luminoso che dava il cambio al sole ai primi albori.
La mia meta era Malindi e la raggiunsi in due ore. Conobbi Popi, il papà dell’Associazione che mi aveva dato la possibilità di iniziare quella esperienza e poi Francesca, studentessa di Medicina, che presto divenne “Mimi Fraha” una volontaria come me. Era il 22 agosto 2009. Chakama ci aspettava il giorno dopo. Ci recammo al villaggio del prete James, invitati alla sua messa cantata e ballata a piedi scalzi, dentro una chiesa senza mura con il solo tetto fatto di paletti in legno che lasciavano oltrepassare il sole. La cerimonia ci aveva presentato per la prima volta i bimbi. I loro grandi occhi erano rivolti verso i nostri visi bianchi e sorridenti. Come uno specchio rispondevano agli sguardi, imitavano i gesti, ci scrutavano come fossimo qualcosa di bello e di insolito e la curiosità di quelle mani piccole e indiscrete, sfioravano le nostre per decifrarne i pensieri. Ci offrirono una bevanda scura in lunghi bicchieri di rame; l’odore era dolce e leggero dal sentore di orzo e cereali. Sul fondo del calice un frutto rossastro, ma in quella occasione lo lasciammo bere alle donne del coro e alle fedeli che con gli occhi chiusi assistevano alla cerimonia, sedute su panche di legno consumato e marcito. L’odore dell’infuso rimase intriso nella nostra pelle e da allora non ci avrebbe più abbandonato.
L’asilo è l’unica costruzione che nasce e supera gli alberi e si scorge prima di arrivare a Chakama. Quel posto era già nel cuore prima ancora di raggiungerlo. Col passare dei giorni un legame intimo, viscerale ed eterno ci rapì senza accorgercene.
I bambini ci osservavano incuriositi e nel corso dei giorni impararono a tenerci per mano e a venirci incontro una volta arrivati e prima di andare via. Iniziarono a disegnare il contorno delle loro dita e a ringraziarci con il musicale “asante” nel prendere dalle nostre mani un pezzo di pane e marmellata.
Noi non pranzavamo, la colazione delle otto precedeva la nostra cena. Ci offrivano bevande calde in bicchieri impolverati e graffiati, macchiati di terra, che lasciavamo bere agli adulti, nonostante spesso fossero i bambini a porgerceli come ringraziamento. Con un po’ di timore e indecisione avvicinavamo le narici al boccale e apprezzavamo con un sorriso quell’odore di orzo speziato portato su dal vapore che durava un attimo e che il calore dell’aria rovente assorbiva e dissolveva. Avvolgeva il nostro viso ed entrava nei polmoni, con un cenno di gratitudine col capo passavamo i bicchieri agli uomini vicino a noi, scegliendo di non assaggiarne.
Sedute a cerchio su grandi tufi le donne sbriciolavano i frutti rossi essiccati, con le mani riempivano, di appena una manciata, il fondo dei bicchieri che tintinnavano in quella cascata di bacche in frantumi e versavano dentro acqua bollente scaldata sul fuoco. Il liquido si colorava di porpora e dopo qualche istante diveniva scuro e intenso. Era kahawa, il loro caffè.
Sommersi da quel profumo osservavamo le loro grandi labbra che succhiavano e assaporavano l’infuso dai calici a volte lesionati, dalle cui crepature cadeva qualche goccia sulla loro pelle scura, ma senza macchiarla. Una di loro, la più giovane, iniziava a cantare con voce nasale e le altre al seguito intonavano versi musicali a noi incomprensibili. I battiti delle mani segnavano il tempo dei lamenti prolungati, mentre i bracciali di legno rintoccavano sui calici di rame come per dare il suono a canzoni senza strumento.
Il rito del caffè si consumava prima del tramonto quando il sole colorava di rosa pure la terra e la bevanda rinvigoriva le corde vocali. I versi accoglievano il tramonto e richiamavano altra gente che giungeva scalza con i bambini per mano. Si cedevano il canto l’un l’altro come se parlassero e raccontassero la giornata appena trascorsa. Avvolti dall’aroma di quell’infuso intenso, che dominava il posto come un vortice di polvere e aromi, il rito consacrava l’unione di tutti i presenti, compresi noi, rapiti da quegli attimi per loro sacri che spesso precedevano l’ora del nostro rientro, quando a malincuore, ci allontanavamo silenziosi per non rompere quell’incantesimo che pure gli alberi udivano.
Portavamo con noi quell’atmosfera artefatta che impregnava i nostri vestiti e che ci accompagnava per tutto il tragitto del ritorno, quando per strada ripensavamo alla gente di Chakama unita da una bevanda che, sovrana della loro cerimonia, li scioglieva e li univa in canti. Ripensavamo ai sapori e agli odori, al loro culto, ai loro visi, mentre percorrevamo le vie di terra e buche e gli alberi di acacia a forma di ombrello scorrevano lungo il finestrino e i sassi, l’erba spinosa e le sedie scavate nella terra, correvano via dai nostri occhi. I bimbi lungo la strada, seduti per terra nudi e soli, attendevano le auto che attraversavano quel sentiero per sollevarsi di scatto e correre a piedi scalzi, duri, instancabili e così forti da far muovere quei corpicini esili e deboli coperti da lembi di stoffa che scendevano penzoloni, brandelli di una maglia o di un pantalone che indossavano gelosamente. Venivano incontro all’auto urlando – Acqua acqua – una parola che hanno imparato da visi pallidi come i nostri che da anni, in sella alle jeep, solcano le loro strade. Non c’era luce in quei posti e nemmeno a Chakama. L’acqua era quella del fiume che dista ottocento metri dalle casette; con la stessa acqua si dissetavano e si lavavano.
Il fiume era alto pochi centimetri, i piedi non affondavano e il colore era scuro come il fango. La gente del posto lo beveva assieme alle zanzare, ma li faceva sopravvivere. Scaldavano quella stessa acqua per preparare il pranzo, un ruvido impasto, e per disciogliere i frutti del caffè nel loro infuso rituale. Un pasto al giorno era la loro razione. La polenta e la verza il cibo; il mestolo era un pezzo di legno ricavato da un albero, il gas era il fuoco, le posate le dita. Il piatto era uno solo per un gruppo di cinque bambini. Sedevano in terra dopo aver lavato le mani in un grosso tino riempito con quella solita acqua e tutti insieme, tutti, immergevano i palmi nel medesimo recipiente. Composti e silenziosi, seduti a cerchio, si spartivano il cibo.
Rientrati in città, nei nostri alloggi, restavamo sul letto prima della cena. Il calore e l’odore dei nostri corpi ci ricordava il rito, i nostri capelli impregnati di quel momento artefatto emanavano profumi di erbe e aromi, seppur avessimo solo odorato quei calici. Le finestre spalancate facevano entrare l’aria della sera nella cappa della stanza e assieme ad essa, risuonava la musica di quei canti e di quella armonia che la loro bevanda sacra riusciva a creare.Il sole era perpendicolare alla terra fin dalle dieci del mattino e per tutto il giorno, poi correva giù e alle diciotto salutava la Natura con colori incantati che nascevano aurei e terminavano violacei sulle case, mentre il cielo di cartone si gonfiava e si allungava nella danza delle nuvole.
Tornavamo al villaggio ogni giorno, i bimbi ci correvano incontro senza scarpe, con i vestiti che venivano loro consegnati, senza mostrare la tristezza perché non possedevano più di quello che potevano avere. I più piccoli amavano le bottiglie in plastica vuote per poterle riempire. Nel tappo infilavano uno stecchino in legno per farci una trottola, la loro meraviglia era nella semplicità di ciò che avevano, senza vizi, senza pretese, senza litigi per qualcosa di grande e di più bello. La purezza e la loro ingenuità erano un dono innato.
Mancavano poche ore prima che quel viaggio meraviglioso volgesse al termine. Stringevo a me Ngina, bellissima, di soli undici anni e le passavo le dita fra i capelli corti e ruvidi dal colore della pece, cercando di trasmetterle tutte le parole che non riuscivo a dirle, poi sui nostri visi le lacrime segnarono le guance, scendendo silenziose. Avevano rigato il mio volto abbronzato di sole e di terra e reso il suo, lucido e fresco. Stringendo le mie mani e poggiando con forza il suo capo sul mio mento, scivolava fino al collo sfregandosi gli occhi bagnati sulla mia pelle impolverata. Allontanatasi per un istante era ritornata davanti a me, tra le mani portava un calice sporco che provava, con il suo braccio nudo, a ripulire dalla terra; ero rimasta seduta mentre lei, con le sue ginocchia vicino alle mie, teneva il bicchiere con una mano e con l’altra prendeva la mia, ponendola sul boccale colmo di nero. Il liquido scuro emanava quell’ormai noto odore di spezie ed erba. La guardavo, mi sorrideva e le risposi con uno sguardo benevolo. Bevvi. Caffè, orzo, cannella, zenzero, chiudevo gli occhi e assaporavo con l’anima quella bevanda molto simile al caffè dei miei risvegli in Italia ma con una nota diversa, acquosa e intensa al tempo stesso. Ingoiai, mentre Ngina prendeva il bicchiere e beveva anche lei. Assaporavamo insieme dallo stesso calice l’infuso, come un rituale sacro di amicizia consacrata con un gesto, posando le nostre labbra sullo stesso boccale, assaporando il gusto l’una dell’altra e fondendo due mondi lontani che in quel momento erano divenuti uno soltanto.
Senza paure, senza più timore dell’acqua che avevo bevuto e dei granelli di terra residui sulla mia bocca, finivo assieme a lei il caffè in infuso. Non sarei più guarita dallo sguardo di Ngina e da quel momento magico che lei, piccola e innocente, timidamente benedì con un suo canto nasale, leggero e soave.
Era l’ultimo giorno, seduta nell’auto con gli occhi lucidi non riuscivo a voltarmi, non avrei trattenuto lo sguardo di quei visi. I bimbi rincorrevano l’auto e tendevano la mano per toccarci, non avevano paura, come noi, che potesse essere un arrivederci troppo lungo, non avevano paura di realizzare, come noi, che stavamo andando via, che i nostri giorni di permanenza erano terminati. Continuavano a correre senza affanno, Ngina era la prima fra tutti e quando allo stremo riuscì a gridare il mio nome, mi voltai e l’arrivederci più bello della mia vita lo lessi nelle lacrime scese assieme, nei nostri mondi ormai uniti, nell’infuso assaporato contemporaneamente, nel suo canto soave e in quel suo ultimo saluto fatto di sorriso, un sorriso forte, più forte di tutto, più forte di me.
Category: Cultura